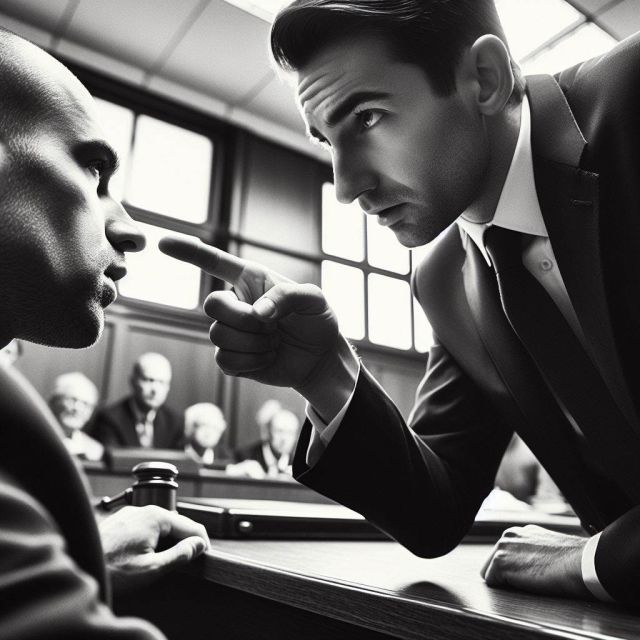Introduzione
Tra le tante frasi che ruotano attorno alla giustizia penale contemporanea c’è quella per cui bisogna difendersi nel processo, non dal processo.
Chiaro il senso: lo Stato ha il diritto/dovere di esercitare la sua pretesa punitiva e di sottoporla al giudice terzo secondo le regole che compongono il giusto processo; l’accusato ha il diritto di contrastarla con pienezza ma solo attraverso gli strumenti messigli a disposizione dall’ordinamento e solo usandoli per raggiungere lo scopo cui sono fisiologicamente preordinati.
Se chi si difende va oltre tali limiti, la sua reazione equivale a negare la legittimità della pretesa punitiva, finendo così per assumere una natura sostanzialmente eversiva.
Condotte normalmente intese come difesa dal processo
La sequenza argomentativa che chiude il paragrafo precedente, formalmente ineccepibile data la sua diretta derivazione costituzionale, deve tuttavia misurarsi con l’eterogeneità delle situazioni che sono state etichettate come difesa dal processo.
Nel tentativo di classificarle anche solo sommariamente, si potrebbero individuare due tipologie: il boicottaggio o la manipolazione interni al processo e quelli esterno ad esso.
Potrebbero rientrare nella prima tipologia le condotte di chi:
- si renda deliberatamente irrintracciabile in modo da impedire o ostacolare ogni comunicazione o notifica che lo riguardi o anche per sottrarsi all’esecuzione di misure cautelari restrittive;
- produca sistematicamente certificazioni attestanti un legittimo impedimento;
- cambi serialmente i suoi difensori, in un vortice di nomine e revoche, allo scopo di lucrare rinvii giustificati dalla necessità del difensore subentrante di studiare gli atti;
- nomini un difensore parlamentare che possa a sua volta servirsi della carica e degli impegni ad essa connessi come cause di legittimo impedimento;
- articoli un programma probatorio difensivo ben più consistente di quanto serva, ad esempio presentando liste testimoniali di centinaia di persone;
- tenti di addomesticare in direzione favorevole alla difesa i testi d’accusa;
- si avvalga di testi di difesa compiacenti;
- alimenti costantemente un clima di acceso conflitto con l’accusa e/o con il giudice;
- formuli sistematicamente eccezioni procedurali a prescindere dalla loro fondatezza in modo da impegnare il giudice e spezzare il ritmo del processo.
Potrebbero rientrare nella seconda tipologia le condotte di chi:
- si avvalga della propria condizione privilegiata, in quanto leader politico e soggetto investito delle più alte cariche istituzionali, per propiziare l’approvazione di leggi ad personam che ostacolino il regolare andamento del processo o ne accelerino la prescrizione o depenalizzino i fatti contestati o, per altro verso, per addurre serialmente ragioni di legittimo impedimento;
- presenti segnalazioni, esposti o denunce nei confronti dei magistrati che hanno un ruolo nel processo;
- alimenti campagne di stampa ostili al processo ed ai suoi ispiratori;
- si presenti come vittima di mala giustizia o perseguitato da accusatori senza scrupoli;
- lamenti la pretestuosa ripetitività delle iniziative penali in danno dell’accusato;
- minacci di ricorrere o ricorra effettivamente alla Corte europea dei diritti umani per lamentare la lesione dei diritti difensivi.
Ognuna di queste condotte, insieme ad altre affini, è stata additata, a torto o ragione, come difesa dal processo.
Condotte non associate alla difesa dal processo ma che dovrebbero esserlo
Esistono altri comportamenti che, sebbene non associati comunemente alla difesa dal processo, producono lo stesso effetto di quelli elencati nel precedente paragrafo.
Provengono tutti da accusati detenuti e sono i seguenti:
- il suicidio: a ben pensarci, il gesto di togliersi volontariamente la vita è la più estrema e radicale forma di difesa dal processo, quella di chi gli si oppone sottraendo definitivamente se stesso non solo alla punizione, se arriverà ma, ancor prima, alla pretesa di infliggerla;
- l’annichilimento del proprio corpo: è il gesto del ristretto che, riducendosi in uno stato di insensibilità alla realtà, si estranea dal processo (si veda la storia dell’uomo che dorme, la si può trovare collegandosi a questo link) o che, smettendo di alimentarsi, cammina fianco a fianco con la morte, sottolineando con ciò il proprio stato di antagonista del processo (un esempio tragico e notissimo è quello della morte per fame di Bobby Sands, chi vuol leggere la storia può farlo collegandosi a questo link);
- l’intasamento della giustizia: c’è chi, come la vedova biblica che assillò il giudice che non le rendeva giustizia fino a farlo crollare per stanchezza, esprime il suo dissenso attraverso la presentazione seriale di istanze le quali, a loro volta, più che esaurirsi in se stesse, esprimono un dissenso e una sfiducia di fondo nell’amministrazione della giustizia alla quale si accompagna, tuttavia, l’intento di uscire dall’invisibilità e di diventare qualcuno di riconoscibile nella sua umanità e nei suoi bisogni (ne abbiamo parlato in un post sul recordman dei ricorsi, la storia si trova a questo link).
Difendersi dal processo: vale anche per l’accusa?
È giunto il momento di affrontare una questione che potrebbe apparire eccentrica ma che, almeno a nostro avviso, non può essere elusa.
Sono solo gli accusati a difendersi dal processo o lo fanno anche gli accusatori?
Il boicottaggio, la manipolazione o quantomeno l’elusione del complesso di regole cui diamo il nome di giusto processo è materia associabile solo a chi ha il dovere di sottostare correttamente all’esercizio della pretesa punitiva nella veste di suo destinatario o anche a chi ha il mandato ad esercitarla?
Chiaro che la risposta deve esser data non sulla base di astrazioni concettuali ma ricorrendo a dati concreti, se ci sono, dai quali ricavare tipologie comportamentali, se ci sono.
Noi riteniamo che ci siano e uno degli scopi di Terzultima Fermata è quello di documentarne l’esistenza.
Li elenchiamo in modo assai sintetico e limitato, non potendo essere questa la sede per un approfondimento sistematico, e premettendo che nella maggior parte dei casi si tratta di prassi sfornite di sanzione ma comunque espressive, a nostro modo di vedere, di una visione distorta:
- irregolarità nell’uso del registro delle notizie di reato, particolarmente riguardo all’iscrizione degli indagati già individuati, così da differire indebitamente il termine di decorrenza delle indagini preliminari; una prassi così diffusa da avere indotto il legislatore a riformare la disciplina delle iscrizioni e ad introdurre procedure di controllo e possibilità di intervento correttivo;
- amplificazione delle imputazioni provvisorie così da rendere possibile il ricorso ad intercettazioni altrimenti non consentite e a misure cautelari altrimenti precluse;
- ricorso alla misura precautelare del fermo, preferibilmente iper-motivato, così da mettere rapidamente in campo un manifesto d’accusa assimilabile per toni e contenuti ad un provvedimento giurisdizionale, senza esserlo;
- comunicazioni esterne all’insegna del trionfalismo piuttosto che della prudenza appropriata in fasi iniziali del procedimento;
- uso delle misure custodiali restrittive come strumento di pressione e anticipazione della pena;
- crescente antagonismo verso la difesa e sottovalutazione del suo ruolo e delle sue prerogative;
- dilatazione della funzione accusatoria, fino ad associarle scopi storici o di sperimentazione di ipotesi scientifiche;
- riproposizione di tesi smentite da decisioni definitive, sul presupposto che la ricerca della verità non possa essere limitata da ostacoli formali;
- straripamento in ambiti di pertinenza del potere legislativo o di quello esecutivo.
Non intendiamo sostenere che tali condotte siano proprie di tutta la magistratura inquirente, al contrario esse ci paiono riconducibili a visioni ed iniziative di singoli individui o di singoli uffici allorché guidati da quegli individui.
Al tempo stesso, tuttavia, di ognuna di esse vi è traccia documentale, a partire da quel grande incubatore che fu l’inchiesta denominata Mani pulite.
Non parliamo quindi di astrazioni ma di fenomeni concreti e reali.
Ci rimane solo un ultimo accenno prima di concludere ed è tratto dalle cronache di questi giorni.
La stampa e gli altri media (a questo link per il reportage del quotidiano Il Dubbio) hanno dato notizia della sentenza emessa il 23 maggio 2024, dalla prima sezione della Corte europea dei diritti umani a conclusione del caso Contrada c. Italia (n. 4) (n. 2507/2019).
Il ricorrente, Bruno Contrada, si è rivolto ai giudici europei lamentando l’illegalità, da un lato, dell’intercettazione di sue conversazioni telefoniche e, dall’altro, della perquisizione della sua abitazione e dei locali a sua disposizione, osservando che tali misure sono state ordinate nell’ambito di un procedimento per omicidio in cui non era direttamente coinvolto.
Con la sentenza sopra menzionata, la Corte EDU, dopo avere ritenuto inammissibile la censura attinente alla perquisizione domiciliare, ha per contro ritenuto ammissibile e fondata, per violazione dell’art. 8 CEDU, quella relativa all’intercettazione e trascrizione delle comunicazioni telefoniche del ricorrente.
Al di là dell’opinione che si voglia avere della sentenza strasburghese, un fatto è certo: un cittadino italiano è stato destinatario (diretto, non casuale) di perquisizioni domiciliari e intercettazioni senza essere indagato nel procedimento in cui tali mezzi di ricerca della prova sono stati disposti.
Un vulnus dovuto ad una lacuna della nostra legislazione, certo, ma anche un certo modo di intendere la funzione accusatoria.
Conclusioni
Torniamo alla domanda di prima, ora che disponiamo di qualche elemento di fatto in più: la lista delle condotte elencate nel precedente paragrafo merita o no di essere considerata come una fenomenologia di difesa dal processo di marca accusatoria?
A noi pare di sì.