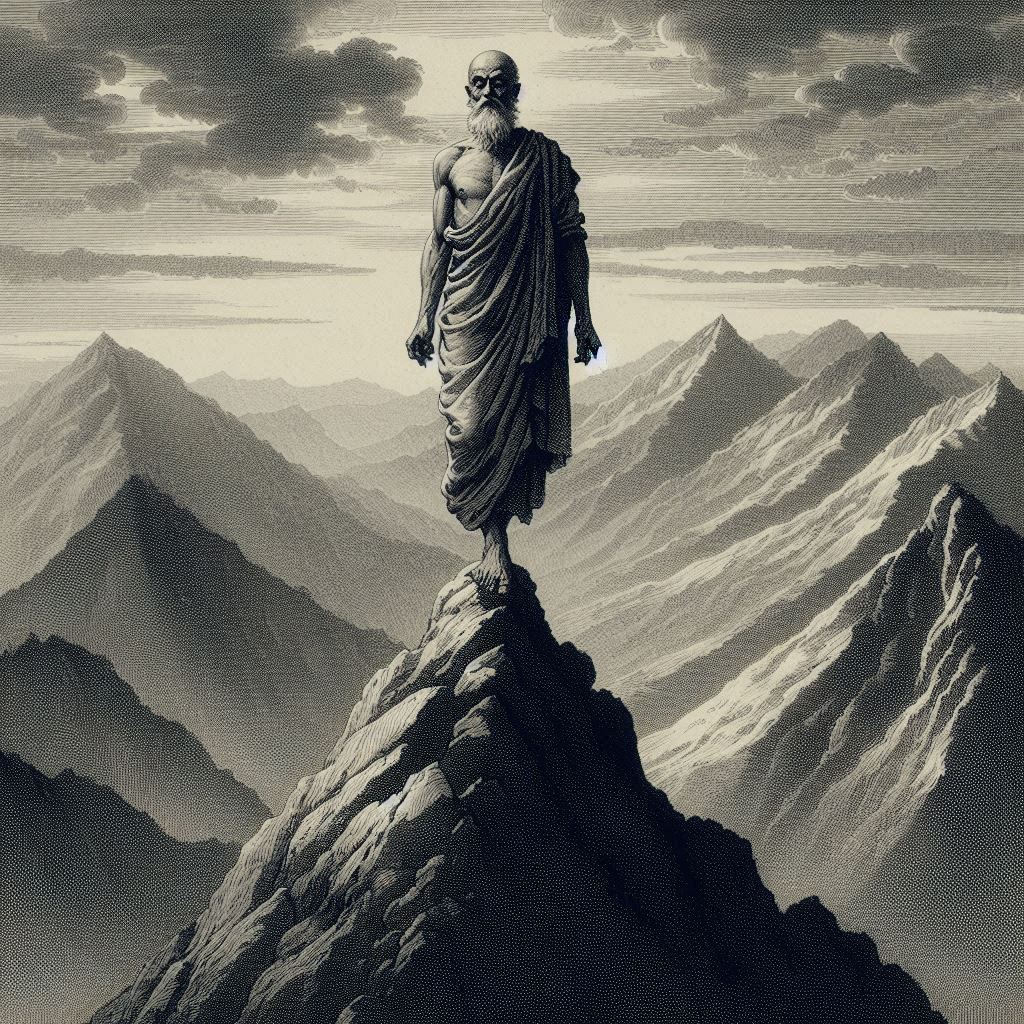Premessa
Il 7 maggio 2025 la Corte ha tenuto l’udienza nella quale la Corte ha trattato e deciso le questioni di legittimità costituzionale poste da ben quattordici autorità giudiziarie in riferimento all’abrogazione del delitto di abuso d’ufficio disposta dalla Legge n. 114 del 2024.
Il giorno dopo il suo ufficio stampa e comunicazione ha diramato un comunicato stampa ove è precisato che “La Corte ha ritenuto ammissibili le sole questioni sollevate in riferimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (la cosiddetta Convenzione di Merida). Nel merito, la Corte ha dichiarato infondate tali questioni, ritenendo che dalla Convenzione non sia ricavabile né l’obbligo di prevedere il reato di abuso d’ufficio, né il divieto di abrogarlo ove già presente nell’ordinamento nazionale” (a questo link per la consultazione).
Lo specifico accenno del comunicato stampa alla Convenzione di Merida deriva dal fatto che vari giudici a quibus (la sezione GUP del Tribunale di Locri, la sezione GIP/GUP del Tribunale di Firenze, la sezione penale del Tribunale di Busto Arsizio, la terza sezione penale del Tribunale di Firenze e la sezione penale del Tribunale di Bolzano) hanno prospettato la possibile illegittimità costituzionale dell’abrogazione della fattispecie dell’abuso d’ufficio per sospetta violazione degli 113 e 117, comma primo, Cost., quest’ultimo per come integrato dagli art. 7, par. 4, 19 e 65, par. 1, della Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea generale il 31 ottobre 2003 (meglio nota come Convenzione di Merida), firmata dall’Italia il 9 dicembre 2003 e ratificata ed eseguita sulla base della legge 3 agosto 2003, n. 116.
L’assunto essenziale di tali questioni era che la suddetta Convenzione rendesse obbligatoria per gli Stati parte la previsione del reato di abuso d’ufficio nei loro ordinamenti e vietasse agli stessi la sua abrogazione ove già esistente.
La Consulta ha dal canto uso escluso l’esistenza sia dell’obbligo che del divieto.
In attesa che la pubblicazione della motivazione faccia luce sul percorso seguito per arrivare a tale esito, proviamo ad ipotizzare gli argomenti che potrebbero essere stati valorizzati a tal fine.
È prezioso in questa ricerca, e costituirà un costante punto di riferimento, uno scritto, di cui si consiglia la lettura integrale per la qualità dell’approfondimento e dell’analisi, di Lorenzo Acconciamessa, “Sull’inesistenza di un obbligo internazionale di stand still e la conseguente liceità giuridica internazionale dell’eliminazione del reato d’abuso d’ufficio”, pubblicato in Diritti umani e diritto internazionale, fascicolo 3, settembre-dicembre 2024, e ospitato nella sezione documenti della Scuola superiore della magistratura (consultabile a questo link).
Il principio dello “stand still”: nozione
Questa locuzione anglosassone significa letteralmente stare fermi.
Traslata nel diritto internazionale, assume il significato dell’obbligo di attenersi allo stato vigente e dello speculare divieto di farlo venire meno con modifiche normative.
Applicato all’abuso d’ufficio, il principio in esame comporterebbe il divieto della sua depenalizzazione, ove la fattispecie incriminatrice esista.
Dubbi sull’obbligatorietà della criminalizzazione dell’abuso d’ufficio
…Art. 19 della Convenzione di Merida
Non pare che questa norma sia utilizzabile a fondamento della tesi dell’obbligo di incriminazione dell’abuso d’ufficio.
Tale articolo istituisce, in effetti, un obbligo internazionale, che tuttavia, come suggerito dal suo tenore letterale, consiste nell’imposizione agli Stati contraenti di un ragionevole sforzo diretto a valutare l’opportunità di inserire la fattispecie criminosa nel loro ordinamento, la quale a sua volta, in virtù dell’art. 65, § 1, della Convenzione implica una valutazione statuale della compatibilità della misura in questione con l’ordinamento giuridico interno.
Non potrebbe soccorrere in senso contrario la tesi della sopravvenienza di una prassi incriminatrice sia perché vi sono Stati che non hanno criminalizzato tale fattispecie di reato sicché difetta il consenso generale, sia perché la prassi è vincolante solo se sia il frutto del convincimento dell’obbligatorietà dell’incriminazione, circostanza, questa, cui è di ostacolo il predetto tenore letterale dell’art. 19.
…Art. 7, § 4 della Convenzione di Merida
A dispetto della convinzione mostrata dai giudici a quibus, i quali hanno sostenuto vigorosamente che tale disposizione, se letta congiuntamente con il già citato art. 19, dimostrerebbe l’obbligatorietà dell’incriminazione, l’art. 7, § 4, è inservibile a tal fine.
Mentre infatti l’art. 19 sancisce obblighi nella materia della criminalizzazione e del rafforzamento legislativo, l’art. 7 tratta misure preventive nel settore pubblico e il suo paragrafo 4 tratta specificamente la prevenzione dei conflitti di interesse.
La Guida tecnica alla Convenzione ONU contro la corruzione emanata dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine chiarisce a questo proposito che gli artt. 7/9 della Convenzione di Merida si risolvono nell’indicazione agli Stati di tenere in considerazione e di sforzarsi di adottare misure volte a garantire la trasparenza nell’ambito del reclutamento di pubblici ufficiali (par. 1), dei criteri per le candidature e posizioni pubbliche (par. 2), del finanziamento dei partiti politici (par. 3) e della prevenzione dei conflitti di interesse (par. 4).
Viene dunque in rilievo un obbligo non di fare ma di impegnarsi a fare o, meglio ancora, di prendere in considerazione la possibilità di fare, il che rende quantomai arduo fondare su di esso un obbligo di fare.
Dubbi sull’esistenza di un obbligo di stand still
Non esiste alcun indizio da cui desumere l’esistenza di un obbligo di stand still generalizzato.
Tanto ciò è vero che gli stessi fautori della tesi affermativa ne traggono il fondamento da specifiche disposizioni pattizie, non essendo possibile dimostrarne la natura di norme consuetudinaria.
Considerazioni sulla compatibilità del reato di abuso d’ufficio con l’ordinamento interno italiano
Posto che, per le ragioni illustrate, deve convenirsi che l’art. 19 della Convenzione di Merida pone un obbligo non di risultato ma di mezzi il quale impegna il legislatore statuale, nella specie quello italiano, a prendere in considerazione, seriamente e in buona fede, la l’opportunità di criminalizzare l’abuso d’ufficio, ne deriva la necessità di valutare se tale fattispecie sia compatibile con i principi fondamentali dell’ordinamento interno.
Tale valutazione, in base ai lavori preparatori che hanno preceduto l’approvazione della L. n. 114/2024, risulta compiuta ed ha messo in luce che i «plurimi interventi normativi volti a dare maggiore determinatezza alla disposizione (effettuati del 1990, nel 1997, nel 2012 e nel 2020» non hanno posto rimedio al consistente squilibrio tra iscrizioni della notizia di reato e decisioni di merito, «anche dopo le modifiche volte a ricondurre la fattispecie entro più rigorosi criteri descrittivi».
Così come risulta la constatazione che la legislazione penale italiana mette in campo «un apparato di repressione estremamente articolato» e che in ogni caso l’abuso di poteri o funzioni o la violazione di doveri imposti dalla legge costituiscono una circostanza aggravante rispetto alla commissione di altre fattispecie criminose commesse dal pubblico ufficiale.
Ciò dovrebbe bastare a supportare la tesi che lo Stato italiano abbia adempiuto all’obbligo sancito dall’art. 19, facendosi peraltro carico di ovviare ai deficit di tassatività e determinatezza evidenziati nel tempo dalla norma incriminatrice.
Note conclusive
Le ordinanze di rimessione degli atti, tutte insieme considerate, hanno chiesto alla Corte costituzionale di spingersi ai confini più estremi delle sue possibilità di intervento.
Il loro eventuale accoglimento avrebbe infatti comportato il riconoscimento dell’esistenza di un obbligo internazionale di fare o, nel caso italiano, di non fare in ambito penale e della sua violazione.
A tale riconoscimento sarebbe seguita la reimmissione forzosa nel nostro ordinamento di una fattispecie abrogata.
Un esito possibile in via astratta ma comunque gravido di conseguenze rilevanti a partire dall’inevitabile ingerenza nell’esercizio del potere legislativo e nella discrezionalità che gli è connaturale, sia pure nel rispetto dei limiti segnati dalla Carta fondamentale e dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Sarebbe stata peraltro un’ingerenza tanto più spinosa data la problematicità, come si è visto, della messa a fuoco degli obblighi effettivamente imposti dalla fonte pattizia internazionale chiamata in causa.
Ugualmente problematico sarebbe stato il governo degli effetti del ripristino della fattispecie dell’abuso d’ufficio sulle condotte tenute sia nel periodo dell’abrogazione che prima.
Quale trattamento si sarebbe dovuto riservare a coloro che hanno tenuto una condotta corrispondente all’abuso d’ufficio mentre la relativa fattispecie era abrogata?
E quale quello da riservare a coloro che l’hanno tenuto prima dell’abrogazione?
Le possibili risposte sono già contenute nella giurisprudenza convenzionale e interna ma ben si comprende l’effetto di confusione e incertezza che un simile balletto avrebbe provocato nei cittadini.
Un guazzabuglio, insomma, fortunatamente disinnescato.